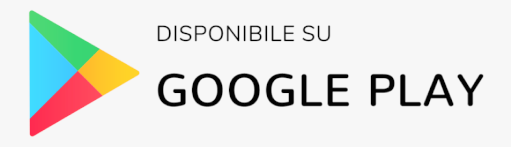206, il prefisso di Seattle, nonché l’appellativo dei nativi della città nello stato di Washington si danno fuori da casa loro. Tra i Nate Robinson, i Jamal Crawford, i Jason Terry venuti fuori dalla città sede della Boeing, ce n’è uno in particolare che merita attenzione per il suo talento, la sua storia e, purtroppo per noi appassionati, anche per la sua sfortuna: brandon Dawayne Roy. Una carriera passata a Portland più una comparsata a Minnesota, ginocchia disordinate come quelle di un crossista ma un talento semplicemente infinito. Giocatore completo, difensore rapido, attaccante perfetto, sapeva far canestro da dovunque e con chiunque davanti, una visione da gioco da point guard consumata che ci ha regalato bei salti dal divano anche quando la palla nel cesto la faceva mettere a qualcun altro, doti da leader carismatico e il suo immancabile sguardo fiero e concentrato. Una macchina perfetta. Un solo punto debole però, devastante per la sua carriera: le sue ginocchia. Brandon soffre di un’artrosi degenerativa alle due ginocchia, in parole più semplici la cartilagine delle articolazioni si deteriora fino a sgranarsi completamente. In queste condizioni è difficile persino camminare bene, figuratevi giocare in NBA. Anno da rookie assurdo, Rookie Of The Year 2006 (ROY in sigla, sembra scritto apposta per lui) a mani basse dopo che dal 2002 in poi, appena uscito dalla high school (la famosa Garfield High School, anche se più conosciuta per i fisici da laboratorio che da NBA) ha rimandato il salto tra i grandi prendendosi nel frattempo la leadership degli Huskies dell’università di Washington (dopo aver giocato con Martell Webster e Nate Robinson) segnando due volte 35 pti come career-high al college e più di 1000 totali. La sua canotta numero 3 è appesa al soffitto della Bank of America Arena e sopra il numero perfetto c’è scritto Roy. Insomma, il gusto di essere il primo giocatore della squadra ce l’ha sempre avuto, come un vero campione.
In NBA viene scelto alla 6 da Minnesota e viene scambiato per Randy Foye, scelto alla 7 dalla franchigia dell’Oregon. Prima partita direttamente a casa sua contro i Supersonics e primo ventello a referto, giusto per far capire che tre anni di college a livelli eccelsi qualcosa contano anche nella Lega. A fine stagione le stats contano quasi 17 punti con 4 e 4 alla voce assist e rimbalzi, e solo 56 partite nel paniere perchè le ginocchia non l’hanno mai lasciato in pace.
Nel 2001 il capitano Zach Randolph parte verso la Grande Mela, così Nate McMillan (che tra l’altro incontrò il Brandon studente durante uno dei suoi camp da giocatore) gli affida le chiavi della squadra insieme all’altro giovincello che si è giocato per molto tempo la palma della miglior ala forte della Lega e all’altro ragazzo draftato per primo, prima di Kevin Durant. Un vero Big Three per potenzialità, purtroppo mai esplose del tutto: Oden giocherà 82 partite (quanto una regular season intera) in 5 anni, Roy comincia la trafila delle 7 operazioni alle ginocchia, 7 come il suo numero di canotta, a cui si sottopone per tornare a giocare a basket. Per regalarci ancora quei salti in avanti verso il canestro con la mano più lontana dall’avversario ad accarezzare la palla, l’eleganza e la naturalezza old school degli anni ’60, quando un suo conterraneo faceva cantare la sua Black Beauty a Woodstock.
Per “The Natural” schiacciare è troppo mainstream, la vera aristocrazia del talento con quella palla ci gioca a biliardo, non a rugby. Siamo nel 2010, comincia l’odissea delle operazioni, la cartilagine è praticamente sparita, Brandon regge botta finché può, poi è costretto a mollare. Questo sarà il suo ultimo anno, chiuso perdendo 4-2 al primo turno dei Playoff contro i Mavs campioni. Roy però ragiona da fiero combattente in prima linea e se Portland è sotto 67-44 a 12 minuti dall’ultima sirena, spallucce, Brandon tira fuori 18 pti in 12 minuti bollenti e i Blazers, come Bruno Pizzul insegna, la portano a casa 84-82 davanti ad un Rose Garden tanto impallidito quanto delirante. Giocando praticamente su una gamba sola. Ah, il gioco da 4 per il pareggio commuove, vi avverto.
Da lì, il nulla. Training camp della stagione 2011-2012, Brandon Roy annuncia il ritiro. Troppo dolore, troppi rischi, troppe incognite anche per un carattere di granito come il suo. Ci ha riprovato successivamente, tornando alla franchigia che lo aveva originariamente draftato e che poi ha rischiato seriamente di mangiarsi le mani per quello scambio con Foye ordito dal GM Kevin Pritchard (quello che ha appena scambiato Paul George ad OKC, per intenderci) ma del Roy di fine decennio c’è rimasto soltanto il ricordo. Chiudiamola qua. Del resto, c’è anche una famiglia dietro a lui, famiglia a cui è legatissimo, una moglie e due figli (si racconta che dopo aver portato la sua signora a vedere qualche anello “giusto per farsi un’idea”, piazza quello scelto nel suo armadio tra le canotte da gioco, esce a mangiare e tramite il telefono invita la moglie a cercare nel guardaroba dicendo”se ci trovi qualcosa dentro, sarà tuo”. Scoperto l’anello, Brandon rientra insieme al loro primogenito dicendo “BJ vuole sapere se mamma sposerà papà”). Fiori d’arancio per loro, alla fine l’NBA Ring non è sempre l’anello che conta. La parabola di Brandon Roy, destinato purtroppo alla sconfitta ma a testa decisamente alta, una battaglia contro il destino persa da eroe, un Achille del 21 secolo nato a Seattle che, come Stazio ci insegna, è stato talmente troppo forte per gli altri che l’unico suo punto debole si è rivelato essere lui stesso, durato forse troppo poco ma vivo e presente nei ricordi di quei fortunati che l’hanno visto e che lo racconteranno come una stella cometa nell’universo NBA, fugace e schiva quanto luminosa e bella.