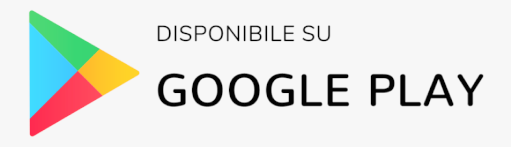ROBINHO (Real Madrid, 24 milioni)
Prendi Robinho, Owen, Essien e Wright Philipps e mettili sul set di un film. Chiamalo pure, “storia di talenti sfioriti troppo in fretta”. Sembra una trama hollywoodiana, di quelle tratte da una storia, purtroppo, vera. Quintiliano li paragonava a delle spighe di grano, i talenti, che come il grano maturano troppo in fretta per poi appassire prima del tempo. Sono gli enfant prodige, che nella cultura del pallone rimandano all’inconfondibile gialloverde della bandiera brasiliana. Ronaldo, Adriano, Pato, Kakà e poi Robinho. Chi per limiti caratteriali, chi per infortuni che hanno dato il via alla parabola discendente, sono usciti troppo presto di scena dall’agorà del pallone, per poi andare a costituire solo un lontano quanto piacevolissimo ricordo. A sentirli nominare, gli daresti 40 anni o più, poi invece scopri che sono quasi nel fiore della maturità calcistica, o appena entrati in quella che viene definita “terza età” dei calciatori, e che magari sono ancora in attività.
“Colpi di testa”, il bisogno di giocare sempre secondo il proprio stile e l’allergia a regole, schemi e allenamenti hanno impedito a quella che sembrava destinata a essere una supernova del calcio moderno di splendere in tutta la sua luminosità. Certo non bisogna dimenticare che quando si parla di Robinho si parla comunque di un campione, capace di indossare le maglie di alcune tra le squadre più forti del pianeta e ovunque di vincere titoli e infiammare la folla: nella memoria collettiva degli appassionati, tuttavia, resterà sempre un fenomeno mancato, sempre vicino alla grandezza assoluta senza mai essere riuscito davvero a raggiungerla o anche solo a sfiorarla. Il debutto nel calcio europeo è decisamente da ricordare, e ancora una volta sembra indicare senza ombra di dubbio in chi lo osserva che si tratta di un vero e proprio predestinato: Robinho arriva a Madrid il giorno precedente la sfida di campionato contro il Cadice, parte dalla panchina e subentra a Gravesen quando mancano 25 minuti alla fine sul punteggio di 2-1 per il Real Madrid. Al primo pallone toccato regala subito una magia, un sombrero sopra la testa di un difensore e via in dribbling, la gioia di correre in mezzo a compagni come Beckham, Zidane, Raul e i connazionali Roberto Carlos e Ronaldo. Quella datata 2007/2008 sarà forse la migliore annata a Madrid di Robinho, che ritorna sui livelli della prima e poi li supera, realizzando 11 reti nonostante un brutto infortunio e trascinando la squadra a una nuova vittoria in campionato. Sarà anche l’ultima, perché dopo aver ricevuto la promessa da parte di Florentino Perez di un adeguamento del contratto il brasiliano scopre che è tutta una strategia della dirigenza per cederlo poi in Premier League al Manchester United, da dove dovrebbe arrivare il nuovo amore del presidente dei blancos, Cristiano Ronaldo. Ma alla fine, senza cambiare volo nè destinazione, si ritroverà tra le fila del Manchester City, allora allenato da Roberto Mancini. Un’avventura iniziata male, con una gaffe e quasi esclusivamente per fare dispetto al Real Madrid, finisce peggio e dopo appena un anno e mezzo: nel gennaio del 2010, dopo altri sei mesi di continui screzi con il nuovo allenatore Roberto Mancini e un solo gol all’attivo, Robinho torna in Brasile, al Santos, un prestito che gli servirà per ritrovare se stesso. Un cerchio chiuso e poi di nuovo riaperto, con un viaggio, ancora una volta, tutto europeo. Come Cristoforo Colombo, ma al contrario: la nuova Europa di Robinho si chiama Milan, club di vertice di una Serie A che è decisamente decaduta rispetto alle altre leghe europee ma che rappresenta sempre un banco di prova importantissimo per un giocatore che ha sfiorato la grandezza e che poi in Inghilterra ha decisamente perso terreno e considerazione da parte dell’opinione pubblica. C’è tuttavia la convinzione che un talento del genere, ad appena 26 anni, non possa avere il meglio già alle spalle. Purtroppo, invece, è proprio così. Come già avvenuto a Madrid e a Manchester, anche a Milano il vero Robinho si vedrà soltanto nella prima stagione, che coincide con la vittoria dello Scudetto e con uno score personale di tutto rispetto: 14 gol in 34 partite in Serie A sembrano un ottimo biglietto da visita per una rinascita completa, ma negli anni successivi, il suo talento sembra ancora una volta, incomprensibilmente e irreversibilmente, sfumare. Quello che verrà dopo, sarà nient’altro che un progressivo puntellamento dell’intera cartina geografica, che lo vedrà far tappa anche in Cina, Russia e Turchia, dove attualmente milita.
Una vita di leziosità, come i tunnel e i doppi passi nella sua indole da fenomeno da baraccone, giocoliere, artista di strada (dove è nato), intenzionato più a far divertire che a far vincere. Ma il calcio è anche tanto altro, il calcio è concretezza, mentalità, lavoro. Ma non provate a dirglielo. Lui se ne frega, e continua a brillare.
JULIO BAPTISTA (Real Madrid, 20 milioni)
In arte, “la bestia”. Tra gol e discontinuità. Tra stelle e stalle. Tra top e flop, apici e abissi, supernove e nubi grigie. La carriera di Julio Baptista, altro rimpianto dell’europa calcistica, perennemente appesa al filo invisibile che intercorre tra riflettori e notte fonda, che nel calcio, si sa, basta un nulla per attraversarne il confine. Altro brasiliano, tanto per cambiare. Ma nell’elite del pallone lui c’è stato per davvero. Di passaggio, quasi da ospite, ha ignorato il cartello con scritto “ingresso vietato ai non addetti” e ci è entrato comunque. Prima il San Paolo, poi i 47 gol in 79 partite con la maglia del Siviglia e la chiamata che non si può rifiutare, quella del Real Madrid: venti milioni al club (tanti considerando l’anno, il 2005) e più di tre al giocatore. Un affare che da top diventa flop nel giro del primo anno. I gol sono nove, ma senza brillare particolarmente, e, col primo aereo per Londra si trasferisce nella capitale britannica sponda Gunners, dove si immerge in men che non si dica nel marasma del bilico tra guizzi e partite poco esaltanti. Segna dieci gol all’ombra del Big Ben, pochi in confronto al suo potenziale. Infatti non bastano, torna al Real, decide un Clásico giocato sotto Natale e poi sparisce di nuovo: destinazione Roma, rivenduto alla metà di quanto era stato pagato.
“Vattene via, vattene via, nun te vojo vedè più, vattene via”.
La disperata sentenza di Carlo Zampa, telecronista giallorosso per eccellenza, in seguito all’ennesimo gol fallito del classe ’81. Che devastante lo era, e lo strapotere fisico non rimase di certo ristretto all’immaginario collettivo, ma peccava di mentalità e cinismo. Troppo spesso in standby nel corso della partita, sembrava disdegnare le cose semplici, a tal punto da risultare goffo e fuori luogo, ed avere un certo feeling per quelle difficili. Giocate impensabili, come la rovesciata contro il Torino che, se si chiede a un romanista qualsiasi di chiudere gli occhi e provare a ricordarsela, di certo non stenterebbe a rivivere la stessa emozione di quel gol allo scadere, che valse i tre punti alla squadra di Ranieri. Il gennaio dopo è già addio: preso a dieci milioni e rivenduto a due e mezzo, direzione Malaga, dove – guarda un po’ – segna a raffica i primi sei mesi e dunque si ferma. Da quel momento la sua storia dice ritorno in Brasile, Orlando in Mls (dove gioca con Kakà e Nocerino) e Cluj, dove invece compare per appena 42 minuti prima di risolvere i contratto. Tra un’avventura e l’altra? È sorprendentemente in campo con le Star Sixes e in un Real-Arsenal leggende, lui che in realtà di mestiere, o almeno fino a poco fa, era ancora un calciatore in attività. La Bestia va in letargo, torna a riposare nei cavernosi meandri che lo hanno accompagnato nell’arco dell’intero percorso professionistico. Con la convinzione, sì, di aver lasciato qualcosa. Ma col rimpianto di non aver fatto abbastanza.
PATRICK VIEIRA (Juventus, 20 milioni)
Classe 1976, nato a Dakar, a ventinove anni è uno dei più grandi centrocampisti al mondo e veste il bianconero dopo avere esaltato per nove anni i tifosi dell’Arsenal ed essere diventato, a furor di popolo, il capitano dei gloriosi Gunners, trascinandoli alla conquista di tre scudetti, quattro F.A. Cup e quattro Charity Shield. Una carriera che già aveva sfiorato il nostro calcio: a diciassette anni era stato per pochi mesi al Milan, sotto la guida di Capello, proveniente dal Cannes, la squadra che lo aveva lanciato. Il Vieira che conquista con la Nazionale francese il Campionato Mondiale 1998 e il Campionato Europeo del 2000, vinto a spese dell’Italia, è qualcosa di più e meglio di qualunque pur lusinghiero pronostico. Che si tratti di fior di campione, lo si nota al primissimo impatto. Nel Trofeo Berlusconi, che costa caro a Buffon seriamente infortunato, Vieira canta e porta la croce, segnando il goal di apertura e correndo come un pazzo, a destra e a sinistra, a pressare e proporre. E in campionato, meglio di così non si può iniziare. A Empoli, alla seconda giornata, si conferma uomo ovunque, anche sotto porta avversaria; il suo goal è dirompente, sembra quasi voler annichilire gli avversari quando avanza o prende posizione sui calci piazzati. Risolve alla sua maniera la delicata trasferta di Udine, appena tre giorni dopo concede il bis a Parma, altro campo tremendo. Una stagione, la 2005-06, positiva, suggellata da prestazioni di spessore, al Mondiale tedesco, con la maglia della Nazionale francese. Poi, il rifiuto di giocare in Serie B e il trasferimento all’Inter.
«La Juve nella quale sono stato io è una delle squadre più forti nelle quali abbia mai giocato e il mio anno a Torino è stata un’esperienza molto positiva. Me ne sono andato dopo un solo anno perché non volevo rimanere in Serie B. Mi è dispiaciuto, ma questa è la vita di un calciatore. Quella stagione in bianconero, però, è stata davvero bella».
In patria lo chiamavano “le poulpe”, “il polipo”, perché amava prodigarsi nella lettura dell’azione e nel recupero del pallone, distruggere e ricreare, come una betoniera. E lo faceva così bene e in modo così pulito che sembrava potesse arrivare su tutti i palloni. Per poi, quasi a smentire la tradizione dei mediani africani e a mettere in discussione lo stereotipo del centrocampista rude ma non troppo abile nella costuzione, palesare le sue immense abilità tecniche e una visione di gioco come pochi. Ci sono, nel calcio moderno, i centrocampisti bravi ad attaccare a quelli bravi a interdire. E poi c’è Patrick Vieira, uno al prezzo di due.
ALBERT luque (Newcastle, 20 milioni)
Lui era molto più forte a FIFA che nella realtà. Per anni è stato l’eterno incompiuto spagnolo, ora a un passo ora a qualche miglia dalla consacrazione. Perché quando cominci a bruciare le tappe finisci per bruciare anche il talento, è quasi un dogma del calcio moderno. Mai affermatosi sul serio, non riuscii a cavalcare l’onda del successo e finì per annegarci. Ora non se lo ricorda più nessuno, e da stella è diventato meteora. Contro i pronostici e al di là dell’auspicabile, perché quelle due stagioni tra le fila del Maiorca lasciavano presagire un futuro migliore. Gente così con le cifre di mercato attuali, vai a pagarla 50 o 60 milioni. Lui andò via per “soli” 20 milioni, che già parevano troppi e assomigliavano a una bestemmia. Tanta corsa, gamba, dribbling, strappi e grandissime intuizioni. Deve aver smarrito il talento, inesorabilmente perso per strada, rubato come in “Space Jam”. Ci sono i giocatori che sembravano vecchi per sempre, dagli albori della loro carriera, e poi ci sono quelli che paiono giovani in eterno, come il ritratto di Dorian Gray. Lui è uno di questi e, a 41 primavere, sembra ancora il ragazzino 22enne che incantava l’Iberostar Estadi. Forse per fermare il fotogramma, bloccare il tempo ed enfatizzare quelli che sono stati gli anni più belli della sua carriera. C’era una volta Albert Luque, il ragazzo con la 7 cresciuto troppo in fretta.
MANICHE (Dinamo Mosca, 16 milioni)
Nel cinema alcuni registi si distinguono dagli altri perché ricorrono ai cosiddetti “attori-feticcio”, ovvero interpreti selezionati appositamente da chi sta dietro la cinepresa perché incarnano alla perfezione la poetica che vogliono andare a rappresentare, in un film o in un’intera filmografia: il caso più comune è quello del binomio tra il regista Tim Burton e l’attore Johnny Deep. Nel calcio, accade qualcosa di analogo tra allenatori e giocatori: un tecnico è capace di portarsi dietro un calciatore in differenti esperienze su diverse panchine, perché incarna al meglio lo spirito che vuole impostare nelle sue squadre. Il “calciatore-feticcio” di José Mourinho, uno dei tecnici più vincenti della storia, si chiama Nuno Ricardo de Olivera Ribeiro, meglio noto con il nome di Maniche. Dopo un anno di esperienza nelle serie minori, Maniche disputa tre buone stagioni con la maglia del Benfica, prima di passare negli acerrimi rivali del Porto, cercato e voluto proprio dallo Special One José Mourinho. Sarà l’inizio dell’età dell’oro, dato che con la maglia dei Dragoes Maniche vince tutto in tre stagioni, nelle quali disputa 80 partite realizzando 15 gol: due campionati portoghesi, una Coppa del Portogallo, due Supercoppe di Portogallo, una Coppa Uefa, una Champions League e una Coppa Intercontinentale da miglior giocatore, seppur sbagliando il rigore finale. Dopo un anno in Russia in forza alla Dinamo Mosca, viene riaccolto nuovamenta dal suo mentore, Mourinho, si trasferisce a Londra, sponda Chelsea, con cui si laurea campione d’Europa.
La parentesi italiana porta il nome di Inter, che se lo aggiudica nel corso della finestra invernale di mercato del 2008. in nerazzurro però Maniche resisterà solo sei mesi, schierato poco da Roberto Mancini e mai convincente, seppur vincitore di uno scudetto. Quasi per uno scherzo del destino, Mourinho, che per lui è stato come Virgilio per Dante e Mazzone per Totti, si accaserà a Milano solo la stagione successiva, quando Maniche avrà già preso la strada di Lisbona, per chiudere il cerchio e così anche la sua carriera.
(Fonte immagine di copertina: Profilo Twitter di Robinho)