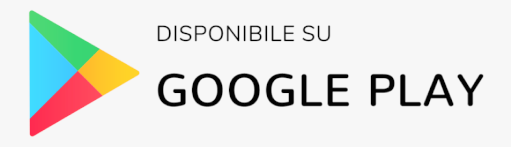Tom Hanks, nel film grazie al quale ha vinto il suo secondo Oscar come miglior attore protagonista, pronuncia su una panchina una frase divenuta a dir poco cult:
La vita è come una scatola di cioccolatini: non sai mai quello che ti capita.
Quattro anni dopo l’uscita nelle sale di “Forrest Gump“, gli Utah Jazz hanno appena plasmato uno di quelle piccole, morbide e dolci delizie: una goduria alla quale gli avversari, cinque ragazzoni in rosso, non possono far altro che assistere, un po’ come l’infermiera di Park Bench in quel dialogo privo di caratteri ordinari.
Il palcoscenico se lo sono preso i due attori protagonisti nel cast che, dal 1991, recita senza sosta al Delta Center di Salt Like City alla ricerca di una definitiva consacrazione sul red carpet cestistico americano. Vivono in Utah rispettivamente dal 1984 e dal 1985, quando vennero selezionati, rispettivamente, con la sedicesima e la tredicesima scelta assoluta: sono John e Karl e questa volta, forse, ce l’hanno fatta.
CIOCCOLATINO
Al latte, bianco o fondente: a voi la scelta, che in questo caso conta veramente poco. Quello che pesa significativamente è il possesso di vantaggio per i padroni di casa, che sono letteralmente trascinati all’estasi da una Rio de Janeiro in pieno Carnevale: manca la samba, ma i 19,911 presenti non lo sanno e ballano comunque.
Stockton, che, come di consueto, governa l’orchestra, serve Malone in post basso e taglia per posizionarsi alla mattonella preferita. Ron Harper segue ma non troppo, circumnavigando a metà nel pitturato; Pippen esita nel cambio, preferendo il raddoppio in aiuto a Rodman. Quando i Bulls sembrano aver elaborato una strategia difensiva, il Postino ha già recapitato la raccomandata a casa del numero 12, che non deve far altro (e dici poco) che avvolgere la retina: è 86-83.
Si iniziano ad intravedere i primi flash ancor prima della sfilata delle stelle: Stockton e Malone, finalmente, riusciranno a baciare l’oro, che sia una statuina ricevuta a Los Angeles o un trofeo da conquistare poche ore dopo a Chicago, in una gara 7 che si preannuncia spettacolare. In campo, però, c’è chi non si trova pienamente d’accordo con questa sceneggiatura; dovreste conoscerlo, ha il 23 e al secolo fa Michael Jeffrey Jordan.

Fonte immagine: profilo Twitter @chicagobulls
COUNTDOWN
Se riavvolgete il nastro nel filmato precedente, potete scorgerlo ad un paio di passi dalla linea da tre punti, pronto a chiudere in caso di scarico su Jeff Hornacek. Quando la conclusione del playmaker avversario ottiene il jackpot nella slot machine a 10 piedi dal parquet, si gira e fulmina Harper con uno sguardo da predatore, in quella gara 6 delle finali NBA che ha molto da condividere con l’ecosistema della savana.
Phil Jackson chiama time-out, perché fondamentalmente è l’unica cosa da fare: studiare uno stratagemma per accorciare il deficit. L’esito è scontato, no? Ora i Bulls entrano in campo e seguono alla lettera lo schema proposto dal coach. Se ci state ancora credendo, andate a leggere qualche postilla nel curriculum del 23 di cui sopra.
Pippen serve Jordan dalla rimessa. Mette palla a terra e punta Bryon Russell, uno che qualche tempo addietro, pochi mesi dopo il primo ritiro del giocatore dei Bulls, gli aveva detto:
Amico, perché hai smesso? Eh, perché hai smesso? Sapevi che ti avrei potuto marcare: dovevi smettere.
Se le ricordava quelle parole, tant’è che lo fa patire per l’intera durata delle finali dell’anno precedente e di quelle in corso. Il canestro che porta Chicago a -1 non fa eccezione: un paio di palleggi, esitazione e cambio di velocità per attaccare; i 206 centimetri di Antoine Carr vanno a chiudere, ma il percorso di quegli spicchi arancioni non può avere esito differente che la samba ballata dal pubblico, nella retina. 86-85.
Sembra iniziato un countdown destinato a plasmare l’entusiasmo dei presenti in un tragico epilogo; tragico per tutti, tranne che per Jordan & Co. Il bello deve ancora venire, ma sarebbe inutile e controproducente farvi indugiare ancora molto.
Il cronometro segna 37,1; sono in arrivo 31,9 secondi confezionati come la scatola di cioccolatini del buon Forrest. Non sai mai cosa possa capitare in una situazione simile, con il Delta Center che trascina letteralmente i padroni di casa verso un nuovo possesso di vantaggio; nessuno lo sa, tranne chi, quella sera, era particolarmente presente nei pensieri degli dei del basket.
SCALTREZZA, FIDUCIA, ONNIPOTENZA
Il primo dei tre elementi è tutto qui, in una decisione tanto azzardata ed audace quanto significativa. Nessuno si permetterebbe di stanziare attorno a Karl Malone in quel momento, specialmente dopo quello che era avvenuto pochi istanti prima; la tripla di Stockton, ricordate? Harper non aveva seguito il movimento del 12, che si è trovato libero al posto giusto, al momento giusto. Ecco, Jordan fa la stessa identica cosa; ciò che cambia è il fine, l’obiettivo.
Rodman è un ottimo difensore, ma Malone è particolarmente in serata: ne ha siglati 31, cosa gli impedisce di aggiungerne due nel tabellino finale? Jordan, però, ha già aperto la scatola di cioccolatini, che sembra più un vaso di Pandora con i segreti del più forte. Strappa la palla dalle mani del 32 come un grizzly con i salmoni controcorrente: è sua. E poi, spazio alle immagini.
Dopo aver eseguito senza problemi il furto in post basso, Jordan si fionda sul lato opposto del campo; Utah si è già schierata, ma qui entra in gioco il secondo elemento: Phil Jackson decide, nonostante le premesse, di non chiamare time-out. Si fida di Michael, che palleggia insistentemente facendo proseguire il countdown.
Russell si rende improvvisamente conto che, forse, non avrebbe dovuto proferire parola. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9… il contro alla rovescia si ferma prima del previsto: mancano 8,8 secondi al termine quando MJ attacca con la mano forte, la destra. Sembra voler puntare il canestro, tanto che Karl Malone intuisce e cerca di chiudere il passaggio in anticipo. Terzo elemento, et voilà.
Jordan si aiuta con la mano sinistra, spostando il baricentro con un palleggio arretrato; Russell è uno dei salmoni che stanno per finire nelle grinfie del grizzly: la preda è caduta in trappola. È solo e mette le ali al pallone, pronto all’atterraggio alla stazione onnipotenza; il rilascio è perfetto, e non ci si aspettava altro. L’esito, ovviamente, lo conoscete e non importa cosa avvenga dopo. 87-86.
Sono 6,6 secondi sul cronometro, per il titolo numero 6. È l’allineamento degli astri. È il cioccolatino da gustarsi sulla panchina. È tutto un altro sport, quando si parla di quel tiro. 22 anni fa, The Last Shot.

Fonte immagine: profilo Twitter @J23app
Fonte immagine di copertina: profilo Twitter @ESPNAusNZ
Crediti video: Sky Sport