Fabrizio De Andrè, poeta dei nostri tempi, cantava, nella celebre “via del campo”, che “dal letame nascono i fior”. Dai diamanti, da quelli no, non nasce nulla. Il che è un chiaro messaggio più o meno esplicito di speranza verso il futuro. La classica luce in fondo al tunnel, la quiete dopo la tempesta, che finchè ci sei dentro ti sembra tutto meno che vicina, quasi utopistica, surreale. Finchè poi non diventa profezia, e allora cominci a crederci.
È il nostro punto zero. Il tunnel in questione ha un nome ben preciso: calciopoli. Lo scandalo che mise a tappeto l’Italia calcistica e che eclissò la supernova tricolore, originariamente destinata a brillare, e ora così tanto fioca e sommessa per essere vera. Era il 2006, l’anno che sarebbe dovuto essere l’inizio della fine, e invece fu solo l’inizio di un nuovo inizio più roseo e fiorente di quanto l’immaginario collettivo potesse lontanamente sognare. Inizio che si materializzò col mondiale di Germania, quando salivamo sul tetto del mondo. Poi, quel “cielo azzurro sopra Berlino” evidentemente non voleva proprio saperne di cambiare volto, tanto che allargò i suoi confini, e la supernova divenne stella polare. In un anno ci prendemmo tutto: il Milan, l'”ultimo” Milan, si risollevò come un toro dalle sabbie mobili di Istanbul, prendendosi la sua rivincita in quel di Atene e portando all’ombra della Madonnina la settima (e ultima) Champions League della sua storia. Cannavaro vinceva, dopo un mondiale da assoluto protagonista, il Pallone d’Oro, l’ultimo assegnato a un figlio dello stivale, mentre Totti indossava la scarpa d’Oro grazie ai 32 gol stagionali che lo scaraventarono sul gradino più alto del podio. Era l’ultima grande Italia, ora con le spalle al muro, ora regina del mondo. Se non uccide, di solito fortifica. E forse De Andrè non aveva tutti i torti..
NumeroDiez, proseguendo quello che sta diventando a tutti gli effetti un appuntamento fisso, è andata ad analizzare il calciomercato estivo della stagione 2006/2007, andando a scovare i colpi più onerosi di quell’anno. Pronti, partenza, via!
ANDRIJ SHEVCHENKO (dal Milan al Chelsea, 45 MILIONI)
Un pallone d’oro alle spalle, una Champions in curriculum, decisa peraltro dal penalty finale contro la Juve, e i quarti di finale conquistati contro la sua Ucraina, che più di qualcuno ricorderà piacevolmente come agnello sacrificale degli Azzurri. Una favola targata Andrii Shevchenko. Poi però, come ogni favola che si rispetti, arriva il cattivo della storia. E’ sovietico come Sheva, ha lo stesso sguardo glaciale e parla la sua stessa lingua. Due destini incrociati. Il cattivo si chiama Roman Abramovich, il “vento dell’est” la sua queste, corteggiata spudoratamente dai tempi degli albori rossoneri. Difficile staccarsi, per questo e per tutte le cose belle che lo legavano al Milan. I primi giorni da studente nella piccola scuola vicino a piazza Duomo, la prima casa in centro con i Giardini di Palazzo Reale intorno, perché la famiglia soffre la mancanza del verde di Kiev. La lunga attesa per uno scudetto e nel frattempo la Champions League del 2003, con tutta una vita di calciatore racchiusa in quei pochi secondi, in attesa del fischio dell’arbitro e del rigore da calciare. Gli occhi freddi prima, e poi la gioia che esplode come una pentola a pressione. Poi arriva il petroliere russo, con le sue lusinghe e i suoi complimenti, e Sheva tentenna perchè in fondo l’idea di una nuova vita a Londra farebbe gola a chiunque. Sheva parte per Londra con un bagaglio di successi e rimpianti. A Londra non è mai il primattore e pian piano perde anche il ruolo di un buon coprotagonista. Schiacciato dall’intesa perfetta di Drogba con Mourinho e dai problemi fisici causati da metodi di allenamento diversi, Shevchenko scompare. Riemerge ogni tanto segnando un gol, ma conquista le copertine soprattutto con i pettegolezzi sul costo della sua casa e delle sue macchine o con improbabili paragoni con le quantità di vodka, caviale o altri generi preziosi che Abramovich avrebbe potuto comprare con i soldi spesi per ingaggiarlo. Sparito dai radar, si mantenne in ombra dai riflettori per due primavere, condite da nove gol in quarantasette apparizioni. Il golden boy diventa fantasma nella nebbia di Stamford Bridge, molto più natura matrigna leopardiana che dolce culla foscoliana. A Londra non lo ricordano con granchè piacere. Ma solo oltremanica.
MICHAEL CARRICK (dal Tottenham al Manchester United, 27 MILIONI)
Michael Carrick, in arte “the underrated one”. Forse perchè era arrivato col blasone e la responsabilità di non dover far rimpiangere, dalle parti dell’Old Trafford, un gigante irlandese del calibro di Roy Keane. Attesa che diventa pressione, pressione che diventa macigno, lo shcema è semplice. O forse molto più semplicemente perchè, quando natura non ti ha dato nè lo spunto della punta nè del 10, quando non cresci con camicia nè piedi buoni, sottovalutato ci nasci e basta. E finchè sei lì, a distruggere e costruire, costruire e distruggere, diventi oggetto misterioso agli occhi dei miopi. Carrick è un centrocampista difensivo, ma ridurre tutto ciò che lui sa fare a questa definizione è quasi offensivo. E le sue abilità nel coprire tutta l’ampiezza del centrocampo, permettono ai Red Devils di schierarsi con un 4-1-3-2 e reggere il peso di un attacco formato da Tevez, Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney. Carrick è una delle pietre angolari di quella straordinaria formazione che nella notte di Mosca vince la Champions. E’ un giocatore ordinato, elegante, imponente ed estremamente calmo. Infonde tranquillità a tutta la metà campo difensiva dei Red Devils, assicurando “distruction & construction“. È un giocatore totalmente diverso dal suo predecessore Roy Keane: l’irlandese pressava (e picchiava) gli avversari, mentre lui pressa gli spazi: soffoca le vie di fuga per le trame avversarie e, in questo modo, ricopre porzioni di campo chilometriche. Un senso della posizione innato, quasi potesse prevedere il futuro, che lo resero uno dei più brillanti tuttocampisti della sua generazione. Una vita allo United, 314 le presenze con i Red Devils di cui fu capitano ma senza fascia, attore ma non protagonista. Una vita dietro le quinte. Una vita da mediano.
MAHAMADOU DIARRA (Dal Lione al Real Madrid, 26 MILIONI)
In arte, lo spaccapietre. Mahamadou Diarra, il ragazzo venuto dal Mali, era muscoli, polmoni e tanto cuore. Una vita nei sobborghi di Bamako, il pallone come valvola di sfogo. Il calcio, come rivincita. Dop un’infanzia professionistica alla corte del Lione, di cui è ancora oggi uno dei giocatori più iconici e rappresentativi, arriva una chiamata, la chiamata, quella che non puoi rifiutare. E’ quella del Real Madrid, che lo preleva nell’estate del 2006 per 26 milioni di euro. In Blancos Diarra sbarca il lunario ma non ostenta, non vive al di sopra di quelle che sono le sue possibilità perchè in quel mondo apparentemente più grande di lui, sembra starci davvero bene. Lo dimostrano a pieno titolo le novanta e oltre apparizioni con la maglia del Real Madrid. Il suo nome comparirà nel tabellino dei marcatori soltanto tre volte, di cui una in grassetto: si gioca Real Madrid-Mallorca, il testacoda valido per il titolo iberico. E’ il 34esimo del secondo tempo, il punteggio è ancora sull’uno a uno, contro pronostici ed auspici. Dopo cinque anni da custode del centrocampo, era come se non potesse essere che lui, per sorte o destino, a regalare a Capello la vetta della classifica. Diarra si libra in cielo, quasi telecomandato da una forza divina, raccoglie un pallone di Raul destinato al portiere avversario e svetta più in alto di tutti per la conquista del titolo. Un gol che vale da solo il prezzo del cartellino. Ma Mahamadou Diarra, la pantera nera dalle lunghe leve e dal cuore grande, è stato anche (tanto) altro.
JOAQUIN (dal Betis al Valencia, 25 MILIONI)
Lo spagnolo che fece innamorare la Fiorentina. Perchè in fondo una città d’arte come Firenze non può che ammirare un artista come Joaquin. Un giocatore capace al contempo di farti innamorare per la sua classe sopraffina e farti arrabbiare perchè ama perdersi nella selva oscura della bellezza delle sue stesse giocate. Dal carattere non ineccepibile, lo spagnolo, andaluso fino al midollo, era serbatoio puro di tecnica e qualità. Dopo un trascorso al Betis Siviglia, a causa di alcune incomprensioni con la società biancoverde, decise di legarsi al Valencia e divenire l’acquisto più oneroso della storia delle murcielagos. Con i pipistrelli disputa la bellezza di 216 gare, collezionando 30 reti e 31 assist e mettendo in bacheca una Copa del Rey.
Se il termine “ala” ha ancora un senso profondo, legato a radici concettuali che affondano nella mistica del numero 7 e nella narrazione del giocatore matto, estroverso e geniale nelle sue scelte in campo così come fuori dal terreno di gioco, allora dobbiamo ringraziare uno degli ultimissimi eredi di quest’epica ormai retrò. Uno dei garanti, nonchè massimi esponenti degli ultimi dieci anni almeno, di una tradizione che trova massima espressione nella figura del genio, del folletto, sgusciante e imprevedibile, rapido e brevilineo, imprendibile.
“I grandi dribblatori che narcotizzano il pubblico con la loro abilità, fanno disperare gli allenatori per la loro indisciplina tattica. Sono solitari e un po’ esibizionisti. Per questo preferiscono la fascia laterale: per allontanarsi dalla squadra e avvicinarsi al pubblico.”
Un gusto tipicamente iberico per le leziosità, per l’eccesso di zelo nel ricamo, volto a dimostrare la qualità del singolo. Narcisismo da cortile. God save the queen, ma, se possibile, anche Joaquin, in quanto emblema dell’eterno numero sette dell’ala spettacolare e a tratti incompiuta, bella ma a tratti non concreta, imprescindibile nell’agorà del pallone. Perchè è anche per loro che amiamo questo sport.
ZLATAN ibrahimovic (dalla Juventus all’Inter , 24,7 MILIONI)
Lui è uno di quelli che non necessita di alcuna presentazione, ma noi, non ce ne voglia, gliela facciamo lo stesso. Col rischio di scivolare nel patetico, che non sia da offesa, ma celebrazione ed emblematizzazione di quello che è stato uno degli ultimi “veri” centravanti sfornati dal calcio moderno. Un ponte, un autentico spartiacque tra passato e modernità, collante tra due figure diverse e a tratti antitetiche, un calderone senza tempo che unisce epoche diverse. Zlatan è passato, presente e futuro. E’ accentratore moderno della manovra offensiva, come le punte vecchio stampo, ma anche il rapace d’area di rigore figlio del calcio moderno. Il contorno, che tanto contorno non è, è un mix di tecnica e atletismo che l’hanno reso il centravanti più forte della sua generazione. Svedese dentro e “zingaro” fuori, ma Ibra è un cosmopolita, un Marco Polo dei nostri giorni, perchè se c’è stato un giocatore capace di tappezzare la cartina geografica come ha fatto lui negli anni, conquistando il mondo neanche stesse giocando a Risiko, con la sfacciataggine e il cinismo che se le cerchi sul dizionario ti esce una sua foto, è stato proprio il classe ’81.
Svezia, Olanda, Italia (per tre), Spagna, Inghilterra e, per non farsi mancar nulla, è riuscito anche a incantare, dove oltreoceano forse è un attimo più facile, anche in America. Col passare del tempo il suo talento si sarebbe spogliato di qualsiasi forma di rancore e negli anni quella di Ibrahimovic sarebbe diventata una forma di superiorità imperturbabile. La superiorità di Ibrahimovic è una forma di contemplazione della sua stessa grandezza, Ibrahimovic che medita su Ibrahimovic. Che poi è espressione stessa della sua arroganza, motivo per il quale a tanti allenatori, da Sacchi a Cruyff, non è mai andato giù. Sono diversi i gol di Ibra che nascono da una scintilla piccola ma così anti-intuitiva da lasciare sbigottiti. Per questo il suo gioco di Ibra non somiglia a quelle opere d’arte che brillano per la purezza delle loro forme ma a quelle che colpiscono per la profondità dell’intuizione da cui sono nate. In quella stagione, quella post-mondiale, Ibra conquistò la Milano nerazzurra a suon di gol e prestazioni maiuscole, unico vero filo conduttore dell’attaccante venuto da Malmoe. Una ricerca continua e quasi ossessiva della perfezione, lui che studiava da Ronaldo (il fenomeno) e si svegliava di notte, come dichiarato da Adrian Mutu, con l’incubo di essere sovrastato e messo in ombra da Ronaldo (Cristiano)
Lui che, come Pirlo e altri campioni, è stato capace di mettere d’accordo tre tifoserie diverse e rivali, che hanno, anche grazie a lui, molto di più da spartire di quanto si possa pensare. I campioni sono innanzitutto questo. E Zlatan lo sa bene.
(Fonte immagine di copertina: Profilo Twitter ufficiale di Zlatan Ibrahimovic)
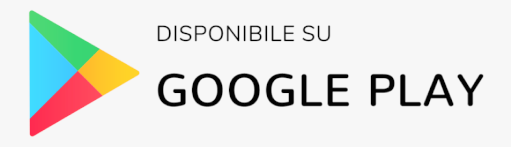




.jpg)


