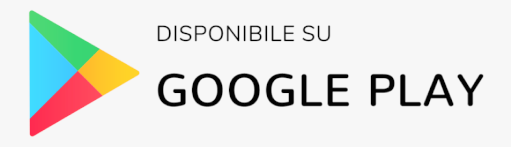Era l’anno della svolta. Sotto tutti i punti di vista. Perchè mentre in Italia l’Inter inaugurava il cammino verso i cinque titoli consecutivi, culminato con la vittoria del Triplete nel 2010, il Barcellona si prendeva la Spagna e tornava, dopo diversi anni di transizione, a figurare tra le regine d’Europa. In Germania, il Bayern Monaco, nel nuovo palcoscenico dell’Allianz Arena, vinceva il suo ventesimo titolo nella storia bavarese, trascinato dai gol di Luca Toni e dalle giocate di un altro “italiano” oggi, Frank Ribery, allora 22enne. Mourinho saliva sul tetto della Premier League al secondo anno sulla panchina del Chelsea, conquistando il terzo scudetto nella storia dei Blues.
Venditti direbbe che “era l’anno dei mondiali”, quelli del 2006, e magari anche che “Francesco Totti era un ragazzo come noi”. Perchè quella stagione si sarebbe conclusa a Berlino, in Germania, dove si realizzò una delle più belle e memorabili favole calcistiche. Travolta dallo scandalo calcioscommesse, che comportò l’esclusione della Juventus dal massimo campionato nostrano, l’Italia risalì dalle sabbie mobili con qualcosa di molto vicino al miracolo sportivo, regalando alla sua gente la gioia del mondiale.
NumeroDiez è andata a scovare i dieci giocatori più pagati della stagione 2005/2006. Tanto per avere un’idea più chiara di quella che è stata, per molti di noi, l’annata che ci ha regalato le chiavi del pallone e avvicinato definitivamente allo sport più bello del mondo.
MICHAEL ESSIEN (Dal Lione al Chelsea, 38 milioni di euro)
I più miopi, o se preferite, i più giovani, lo associano erroneamente alla stagione in rossonero del 2015, in cui venne buttato nella mischia di un Milan in preda al marasma dei decimi posti, nel corso della quale il mediano ghanese parve un vero e proprio “imbucato”. Come ad una festa, quando non ti invitano e te ne stai lì nella speranza di non farti notare. Che poi, parliamoci chiaro, quella del Milan somigliava a tutto fuorchè ad una festa. Ma Michael Essien è stato tanto e tanto altro. Lo chiamavano il “bisonte”, e un motivo ci sarà. Acqua: no, non era lento e nè tantomeno macchinoso. Quel bollo – filo conduttore nel corso di tutta la carriera del classe ’82 – gli fu conferito dai tifosi Blues per via dello strapotere fisico e l’immensa abilità nell’interdizione che lo contraddistingueva. Un muro, una diga, un frangiflutti. Si fece le ossa, e il nome, nel Lione campione di Francia del 2005, con cui conquistò, a livello personale, il titolo del miglior giocatore dell’intera annata transalpina. Ma la vera apoteosi arriva col Chelsea di Mourinho, dove si aggiudica, in men che non si dica, la maglia da titolare. Il calcio non è soltanto dribbling, giocate, gol clamorosi, tunnel, intuizioni geniali. E forse è meglio così. Perchè poi vai a vedere che servono gli uomini-garanzia, quelli su cui fare sempre affidamento, quelli che fanno il lavoro sporco e danno tutto. Lo sa bene Essien, autore di sette stagioni da mastino all’ombra del Big Ben, che era muscoli, corsa e visione di gioco. Un mix devastante, che ne fece uno dei mediani più forti dell’intero panorama europeo, secondo molti al pari dei vari Xavi, Scholes e Pirlo. Quello che ne seguì fu soltanto lo sfortunato tramonto di un campione che vide plumbei bagliori al Real Madrid e poi notte fonda al Milan di Inzaghi. Una carriera che volse al capolinea forse troppo presto, all’alba dei trent’anni, complici anche diversi problemi fisici che ne compromisero quella che in gergo viene definita “pensione calcistica”. Forse aveva finito la benzina, ma, per i campioni come lui, la sfioritura è solo una fievole macchia di un cammino eccezionale.
SHAUN WRIGHTT-PHILLIPS (Dal Manchester City al Chelsea, 31.5 milioni)
Talento grezzo, a tratti inespresso, forse non completamente compreso e apprezzato, più di quanto non dicano trofei e premi individuali. Shaun Wright-Phillips era il prototipo dell’esterno inglese: rapido, devastante in campo aperto, ubriacante nei dribbling e grande senso del gol. Era nato a Greenwich, la città del meridiano che unisce i due poli. E forse era anche per questo che l’ala britannica, tanto per onorare le sue origini, decise di diventare un autentico pendolino, una sorta di collante tra attacco e difesa, capace di svolgere entrambe le fasi con una naturalezza quasi innata. La crème de la crème la vive proprio con la squadra londinese, con cui, dopo una partenza sincopata, si mette subito in mostra come uno dei più grandi talenti dell’intera Premier League. Dopo due stagioni giocate ad alti livelli, fa ritorno al City, la squadra che lo aveva lanciato e acceso i riflettori sul classe ’81. Partito in alto nelle gerarchie, il suo ruolo nei Citizens parve assumere un aspetto sempre più marginale, finchè non divenne un fantasma con gli arrivi di David Silva e Milner.
Cambiò aria, in modo drastico e deciso, accasandosi oltreoceano per fare le fortune dei RedBull New York, club in cui militava, tra gli altri, suo fratello Bradley. La Grande Mela non lo aiutò però a “mettere le ali” e, dopo un trascorso in seconda divisione, decise di appendere gli scarpini al chiodo.
Ancora oggi, guardandosi indietro, Shaun avrà modo di pensare a tutto ciò che poteva essere e che, per un motivo o per un altro, non è stato.
SERGIO ramos (Dal Siviglia al Real Madrid, 27 milioni)
I campioni passano, vanno e vengono. Le bandiere no, restano per sempre. In Castiglia dalle parti di Madrid, bandiera, o bandera, rima con Sergio Ramos che appunto, di campioni, in quattordici anni di Blancos ne ha visti passare tanti: Ronaldo, Raul, Higuain, Hierro, Zidane, Figo, Casillas, Kakà, solo per citarne alcuni. Facile rimanere fedeli a quello che è stato, e continua ad essere, uno dei club più forti del mondo, si potrebbe pensare. Eppure il recente cammino della squadra madrilena, al contrario di ciò che potrebbe sembrare, non è sempre stato rose e fiori, caviale e champagne. Prima della sfilza di Champions League che ha contribuito a incrementare il palmares della squadra di Florentino Perez, il club ha dovuto fare l’ombra perenne del Barcellona di Guardiola. Un periodo quello, dove il Real pareva molto più comprimario, rilegato guastafeste, che assoluto protagonista. E nell’arco di tutto questo periodo, fino alle varie salite e discese dal tetto d’Europa, Sergio Ramos ha rappresentato probabilmente l’elemento più decisivo ed influente, capace di tirare le redini della squadra nel momento in cui i campioni venivano meno. C’è una partita che forse è lo specchio più eloquente e iconico della sua clamorosa carriera: la finale del 2014, uno dei tanti derby vinti contro l’Atletico Madrid, in questo caso tracollo sfiorato, per lungo assaporato, ma evitato. Evitato da lui, con il 4 sulle spalle ma il “nueve” sotto la maglia, che quella sera di maggio a Lisbona sale in ascensore e svetta più in alto di tutti mandando il match ai supplementari.
A fine gara il tabellino dice “4-1”, ma le reti realizzate oltre i tempi regolamentari sono state niente più che fiero contorno all’eroica rete di Sergio Ramos. Che di mestiere non è ancora chiaro cosa faccia di preciso e che sulla carta d’identità, alla voce “professione”, deve averci scritto “un po’ di tutto”. Segna e difende, difende e segna, nel tempo libero batte anche rigori (che rigori!) e punizioni. Per molti uno dei centrali più completi della storia del calcio.
Per non farsi mancar nulla indossa altrettanto bene la fascia delle Furie Rosse con cui abbellsice il giocatore, dopo Casillas, con più presenze in assoluto.
La Coppa del Mondo del 2010 non l’ha alzata lui; ma i trofei sono un po’ come i figli: sono di chi li cresce e se ne prende cura dall’inizio alla fine. E lui di trofei ne sa certo qualcosa in più degli altri.
MICHAEL OWEN (Dal Real Madrid al Newcastle, 25 milioni)
Lo schema è semplice: su un estremo il fenomeno affermato, Lionel Messi, sull’altro il totale incompiuto, Freddy Adu. Ma c’è stato un giocatore capace di sfuggire a questa dicotomia e piazzarsi lì nel mezzo: un ragazzo che a 21 anni aveva vinto tutto, e che a 25 aveva già imboccato un’interminabile parabola discendente. Questa è la storia di Michael Owen, il ragazzo che doveva salvare l’Inghilterra, ma che fu solo un grandissimo attaccante.
Owen è pronto per qualsiasi cosa gli si pari davanti. Niente può spaventarlo.
Michael, all’età di 18 anni, non è più solo il figlio di Terry, calciatore inglese degli anni ’70, è il talento più cristallino di una new wave che l’Inghilterra sta aspettando da decenni. Assieme ai vari Fowler e Beckham, Owen può far dimenticare le delusioni che hanno ciclicamente colpito i Tre Lioni concluso con lo shock dei rigori persi in semifinale con la Germania durante il casalingo Euro ’96.
Il 6 maggio 1997 Michael Owen debutta in Premier League segnando contro il Wimbledon: il suo Liverpool perde però 2-1 consegnando il titolo nelle mani dello United di Cantona. Anche con la maglia dell’Inghilterra, Owen brucia tutte le tappe: segna al debutto con l’Under 15, l’Under 16 e l’Under 18 e nel febbraio 1998 diventa il più giovane esordiente e marcatore della Nazionale maggiore.
Numeri che, assieme al titolo di capocannoniere del campionato 1997/1998, ne legittimano a pieno titolo la convocazione per Francia ’98.
È il 30 giugno 1998 e a Saint-Étienne va in scena contro l’Argentina il match che renderà Owen immortale, cristallizzandone il ricordo e la reputazione a 19 anni. Dopo 10’ di gioco i due uomini più attesi, Batistuta e Shearer, hanno già timbrato il cartellino. Al 16′ minuto Owen rincorre un rilancio della difesa inglese, brucia in velocità Chamot e Ayala e insacca alle spalle di Roa. È la risposta inglese al gol del siglo: il golden boy che emula il Pibe de Oro, in un gioco e in un risultato che sarebbero perfettamente speculari senza il pareggio di Zanetti e la successiva lotteria dei rigori. L’Argentina passa ai quarti e gli inglesi tornano ancora una volta a casa a mani vuote o quasi. Perché la speranza è diventata certezza: Owen è già il leader della Nazionale del domani.
Il 2000/2001 è la stagione della sua consacrazione definitiva: agli ordini di Houllier, il Liverpool vince cinque coppe. I Reds alzano Coppa di Lega, FA Cup, Charity Shield, Coppa Uefa e Supercoppa Europea. Ancora oggi, la finale di FA Cup è ricordata come “la finale di Owen”: una doppietta negli ultimi 10’ ribalta il risultato e affonda l’Arsenal. Anche in Supercoppa Europea è Owen che segna il gol decisivo al Bayern Monaco vincitore della Champions.
Quell’anno dopo l’Europeo arriva una chiamata alla quale Owen non può dire di no: il Real Madrid dei galacticos è pronto a sborsare per lui 17 milioni di sterline. Se a 12 anni Michael aveva scelto senza esitare il Liverpool, a 24 accetta con lo stesso entusiasmo la corte di Florentino Perez. La campagna d’Inghilterra del Real Madrid si completa con l’acquisto di Jonathan Woodgate per 14 milioni di sterline: un’operazione che si rivelerà uno dei più clamorosi flop nella storia del calciomercato. Le cose in Spagna non vanno come sperato e la stella di Owen comincia progressivamente ad eclissarsi sempre di più. Ne rimarrà un bagliore, capace di far gola al “solo” United, che nel 2008 gli affida la 7 di Best e Cantona, e le chiavi della rinascita. Owen si ferma all’Old Trafford per tre anni, alternando gol a brevi stop per infortunio: resta comunque un comprimario, incapace di un apporto costante e decisivo per le sorti della squadra.
Sono passati 14 anni da Francia ‘98, e sul viso di Owen si vedono tutti: c’è tempo solo per un ultimo atto, allo Stoke City. Nella stagione 2012/2013 Michael gioca 8 partite e segna un solo gol, prima di annunciare il ritiro a fine stagione. Alla sua ultima partita, il 29 maggio 2013, i tifosi di Stoke e Southampton gli tributano un’indimenticabile standing ovation.
“There’s only one Michael Owen.”
Cantano per il talento incompiuto più vincente della storia, ben sapendo che quello che è stato è infinitamente meno di quello che sarebbe potuto essere. Guardano quelle ginocchia fragili, ma vedono il ragazzo cristallizato a 19 anni che corre a Saint-Étienne e fulmina l’Argentina. Perché quel gol è come il primo bacio: ha dentro la promessa di tutto ciò che può accadere dopo. E tanto basta per renderlo immortale.
ALBERTO GILARDINO (Dal Parma al Milan, 25 milioni)
Se esiste una linea che separa gli ottimi giocatori dai grandi campioni, tale Gilardino Alberto ha passato gran parte della sua carriera a fare avanti e indietro. Che sia successo “per la voglia di fare tutto e magari subito” sembra più un cliché, un marchio superficiale da attaccare addosso a un diciassettenne pieno di talento.
Gilardino è nato il 5 luglio del 1982. Il giorno della tripletta di Paolo Rossi che schianta il Brasile e manda l’Italia alla semifinale contro la Polonia, ai Mondiali di Spagna. Nato col gol nel DNA insomma, con un anagrafe che idealmente pesa come un macigno. Se fossimo chiamati a scegliere una parola che più di tutte rappresenta la carriera di Alberto Gilardino, sarebbe proprio “gol”. Ma non da bomber di provincia, lui che era nato con la camicia nel giorno in cui schiantavamo il Brasile. E magari non è solo questione di coincidenze se, nell’arsura estiva di un ormai lontano 2005, mentre l’intero calciomercato gli gira attorno, i giornali scrivono sentenziosi:
«…dai tempi di Paolo Rossi l’Italia non ha un centravanti di questa forza e queste caratteristiche».
L’estate del 2005 è per il Milan la prima post-Istanbul (o Caporetto rossonera, che dir si voglia). C’è aria di rinnovamento, e Gilardino si divide la maglia da titolare con tali Shevchenko e Inzaghi, accumulando gol e presenze. In estate ci sono i mondiali, ma in Nazionale la concorrenza è ancora più folta: ci sono due giganti come Totti e Del Piero, l’intramontabile compagno di squadra Inzaghi, il rapace Toni e il buon Iaquinta. L’apice del suo Mondiale lo vive, come buona parte della nostra armata malata quanto invincibile, in semifinale contro i padroni di casa della Germania, dopo aver calcato i prati tedeschi soltanto da comparsa. Dopo aver colpito un palo nel primo dei due tempi supplementari, quasi per ironia della sorte, il destino gli restituisce la gioia di finire di diritto tra i protagonisti del match.
Nel leggere le prossime righe si riproietterà nella testa di ognuno di noi, esattamente scandita e lenta, secondo dopo secondo, QUELL’AZIONE.
È il 122′ si è 1-0 e Gilardino fa una cosa clamorosa. Da quando è bambino, tutti gli allenatori che ha avuto gli hanno insegnato che in casi come questi può fare tre cose. Primo: trovare lo spazio e calciare. Secondo: fermarsi, cercare il fallo, far salire la squadra. Terzo: andare a tenere palla vicino alla bandierina, come gli grida Caressa dal suo stanzino. Gilardino fa la quarta cosa, quella che sanno solo lui e Alex, quella impossibile e contro natura: si accentra, si guadagna lo spazio per tirare (…quella prima cosa) ma con freddezza spaventosa, senza guardare, passa a Del Piero, che sta arrivando alle sue spalle. Gol.
Andiamo a Berlino!!!
Dopo la dolce esperienza rossonera, il bomber di Biella passa alla Fiorentina, dove vive quattro delle più rosee stagioni dal punto di vista realizzativo. In coppia con Mutu, mette a referto 48 gol in 118 partite, superando Inzaghi nella classifica dei marcatori della Serie A. Dal 2012 è andato bazzicando per i club di provincia, tra cui Empoli e Spezia, intervallati dal trascorso al Palermo. Bazzicando ma non passeggiando, la carriera dell’eterno ragazzino si conclude in maniera tutt’altro che brusca, ma dignitosa, sempre all’insegna del gol.
Ah, a proposito di gol: nel 2009 Povia pubblica un album intitolato “Centravanti di Mestiere”, ispirato per bocca dello stesso cantante milanese, proprio all’Alberto nazionale.
Nel testo della canzone che dà il nome all’album, tanto per tornare al discorso iniziale, c’è una frase che più di tutte è metafora della carriera del bomber lombardo. Non ve la diciamo, provate a capirla da soli.
(Fonte immagine di copertina: Profilo Twitter di Alberto Gilardino)